Come sex coach, mi capita spesso di lavorare con chi si riconosce in esperienze corporee, affettive o sessuali non conformi alle aspettative sociali. Lo vedo anche quando si parla di disabilità: la sessualità viene ancora trattata come un tabù, un argomento scomodo o, peggio, un privilegio da concedere.
Ma la sessualità non è un lusso. È una parte centrale del benessere, della salute, della dignità.
E il 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità, è il momento giusto per valorizzare un bisogno reale, non accessorio: le persone con disabilità hanno pieno diritto di accedere alla propria vita affettiva, sensuale e sessuale, in modo libero, informato e protetto.
In questo articolo esploro il tema da più angolazioni - diritto, linguaggio, lovegiver e contesto italiano - con uno sguardo concreto, non ideologico.Lo faccio con il mio approccio da coach: pratico, rispettoso, orientato alla realtà di chi lavora e di chi vive questi temi in prima persona.
Sessualità e disabilità: ripartire dal diritto
Nel mio lavoro di sex coach, una delle cose che emergono più spesso è il bisogno profondo di sentirsi autorizzatə a desiderare, non come concessione, ma come diritto. Per le persone con disabilità, questo desiderio si scontra ancora con barriere culturali, emotive e strutturali. È per questo che parlare di sessualità come diritto non è solo una scelta politica, ma una pratica concreta di riconoscimento e cura.
La Giornata internazionale delle persone con disabilità è un’occasione per guardare alla sessualità non come a un “extra”, ma come a una dimensione essenziale della qualità della vita. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ci ricorda che partecipazione, autonomia e benessere includono anche l’area affettiva e sessuale. La definizione dell’OMS rafforza questo messaggio: la salute sessuale non è solo assenza di malattia, ma benessere fisico, emotivo, relazionale e sociale.
Perché allora, nella realtà quotidiana, il desiderio di una persona con disabilità viene ancora trattato come qualcosa da evitare o da medicalizzare? Il motivo non è tecnico, ma culturale: si continua a pensare che corpo, piacere e disabilità siano incompatibili. Ma non è così. Quello che serve è una trasformazione profonda di prospettiva e di linguaggio.
Come sex coach, credo che il primo passo sia restituire alla sessualità la sua piena dignità. Non serve “normalizzare” il desiderio: serve ascoltarlo, rispettarlo, renderlo possibile. Questo significa garantire accesso a informazioni chiare, spazi adeguati, professionisti formati, e soprattutto, una cultura che non abbia paura di nominare il piacere e il consenso anche quando si parla di disabilità.
Quali barriere rendono difficile vivere una sessualità piena
Le barriere non sono solo fisiche. Nel mio lavoro le vedo ogni giorno anche sotto forma di messaggi impliciti: “Non dovresti pensare a queste cose”, “Hai già abbastanza problemi”, “Non è una priorità”. E così la sessualità diventa un tema rimandato, rimosso o ridotto a funzione.
Le barriere materiali - come l’assenza di spazi accessibili, la difficoltà a spostarsi o la mancanza di assistenza - sono reali e importanti. Ma le barriere emotive e culturali pesano altrettanto: l’idea che la persona con disabilità debba essere protetta, gestita, infantilizzata. Non viene vista come un soggetto erotico, ma come un corpo da curare o da contenere. Questo non solo limita il diritto al piacere, ma spesso impedisce anche l’educazione al consenso, alla comunicazione e all’ascolto dei propri limiti.
Un’altra barriera, più sottile ma altrettanto potente, è quella linguistica e informativa. Le persone con disabilità - in particolare con disabilità cognitive o comunicative - hanno meno accesso a contenuti che parlano di sessualità in modo inclusivo, chiaro e rispettoso. Manca l’educazione sessuale accessibile, manca la formazione per chi accompagna, mancano le parole per dire “sì”, “no” o “ho bisogno di…”.
Quando si comincia a fare spazio a queste barriere - a nominarle, ad attraversarle con consapevolezza - qualcosa cambia in profondità: la persona riscopre un senso di integrità, di valore e di possibilità reale di scelta. Non servono soluzioni perfette, ma un cambiamento di prospettiva.
Come dico spesso ai miei clienti: la sessualità non è un premio da meritare, è uno spazio da abitare, con rispetto, con sicurezza, con libertà.
Figure professionali e supporto alla sessualità: tra lovegiver, OEAS e accompagnamento consapevole

Quando si parla di sessualità e disabilità, uno degli snodi più delicati è: chi può offrire supporto, in che modo, e con quali competenze?
Negli ultimi anni, anche in Italia, si è fatto largo il termine lovegiver — un termine nato per semplificare ma che, a volte, rischia di confondere. Il nome più preciso e corretto è OEAS: Operatore per l’Emotività, l’Affettività e la Sessualità. Si tratta di un profilo che nasce con l’intento di offrire accompagnamento corporeo, relazionale ed emotivo in contesti di disabilità, senza sconfinare in ambiti che non siano chiari, tutelati o formati.
Come sex coach, vedo ogni giorno quanto sia urgente avere riferimenti etici e professionali. Non per “controllare” il desiderio, ma per renderlo praticabile in uno spazio sicuro, dove ogni parte coinvolta si senta rispettata.
L’OEAS lavora in una zona di intersezione tra educazione sessuale, supporto alla corporeità, empowerment e ascolto. Non sostituisce la relazione, non offre prestazioni sessuali in senso commerciale, ma accompagna un percorso che ha come obiettivo l’autonomia, il benessere e l’autodeterminazione.
Perché è importante distinguere ruoli, bisogni e contesti
Quando si affronta questo tema con le famiglie o con le strutture sanitarie, le prime domande sono sempre cariche di preoccupazione: “Ma è legale?”, “E se succede qualcosa?”, “Non sarà troppo?”. Dietro queste domande si nasconde un nodo più profondo: la difficoltà a vedere la sessualità come parte della vita, anche nella disabilità.
La figura dell’OEAS, così come viene proposta nei progetti italiani più strutturati e trasparenti, non è una figura improvvisata. Richiede formazione, supervisione, codici etici, e un contesto chiaro di applicazione. Non è prostituzione, non è terapia, non è volontariato: è un ambito nuovo, che va costruito e regolamentato con attenzione, proprio per evitare zone grigie.
Per questo, distinguere tra i diversi tipi di supporto è essenziale. C’è un’enorme differenza tra offrire educazione al consenso e gestire un bisogno sessuale con strumenti professionali, e agire in modo ambiguo, senza trasparenza o tutela. Il problema non è parlare di sesso, ma la mancanza di riferimenti affidabili per affrontarlo nel modo giusto. Il problema non è offrire accompagnamento, ma non avere regole chiare su come farlo e con chi.
Nel mio lavoro, accompagno anche educatori e operatori a sviluppare uno sguardo più aperto e competente su questi temi. E quando le parole cambiano - quando si passa da “non è possibile” a “come possiamo farlo in modo sicuro?” - si apre un varco in cui possono nascere connessioni più autentiche, accessibili e sane.
Il quadro italiano: tra vuoti normativi e responsabilità locali
In Italia, il tema dell’accesso alla sessualità per le persone con disabilità è ancora immerso in una zona grigia legislativa. Non esiste una legge nazionale che riconosca ufficialmente la figura dell’OEAS o che disciplini l’assistenza alla sessualità.Questo vuoto non è solo un problema giuridico, è un blocco culturale: senza riferimenti chiari, tutto rimane sospeso tra opinioni, paure e reticenze.
Come sex coach, mi trovo spesso a rispondere a domande come: “Ma se accompagno una persona con disabilità, rischio qualcosa?”. La verità è che molti professionisti sono disposti ad attivarsi, ma non sanno come muoversi senza tutele e linee guida. Questo alimenta un clima di incertezza, dove il desiderio viene spesso ignorato per “non sbagliare”.
Eppure, negli ultimi anni si sono mossi alcuni passi importanti. Nella XIX Legislatura è stata depositata una proposta di legge per l’istituzione dell’OEAS, che include standard formativi, codici etici e supervisione. Un tentativo concreto di uscire dal tabù e portare il tema in uno spazio di responsabilità condivisa.
Nel frattempo, diverse progettualità locali - in ambito educativo, sanitario o sociale - hanno iniziato a costruire piccoli modelli operativi, basandosi sulla formazione, sulla trasparenza e sulla relazione tra pari.
Il punto centrale è questo: senza una cornice nazionale, la qualità dell’intervento dipende dalla sensibilità dei singoli. Una struttura può fare moltissimo, così come una famiglia informata o un operatore formato. Ma non dovrebbe essere una responsabilità individuale. Parlare di accesso alla sessualità significa parlare di diritti che, in quanto tali, non possono essere lasciati al caso.
Come costruire percorsi responsabili anche senza una legge
Il fatto che non esista ancora una legge nazionale non significa che dobbiamo restare immobili. Al contrario, proprio l’assenza di una norma univoca rende ancora più urgente attivare strumenti concreti.Nel mio lavoro lo vedo ogni giorno: non bisogna avere tutto sotto controllo per iniziare a fare passi nella direzione giusta.
Per esempio, una struttura residenziale può già oggi creare una policy interna sulla privacy, sul consenso e sull’educazione sessuale accessibile. Può formare referenti, definire protocolli per l’attivazione di percorsi individualizzati, garantire spazi sicuri per parlare di emozioni e desideri.
Le famiglie, dal canto loro, possono chiedere informazioni, confrontarsi con professionisti esperti, e favorire l’autonomia delle persone che accompagnano, senza cadere nel controllo o nella negazione.
In definitiva, anche in assenza di una legge, è possibile fare bene. Conoscere, formarsi, usare parole chiare, rispettare i limiti e attivare reti sono tutte pratiche che, giorno dopo giorno, costruiscono possibilità reali, sicurezza e rispetto.
E più queste pratiche si diffondono, più diventano patrimonio collettivo — a beneficio di chi lavora, di chi accompagna e di chi desidera vivere una sessualità libera, sicura e soddisfacente.
Parole che aprono spazi: il linguaggio del consenso e della dignità
Quando si parla di sessualità e disabilità, le parole non sono mai neutre. Possono creare spazi di possibilità o, al contrario, rafforzare stereotipi e silenzi. Come sex coach, lo vedo costantemente: la qualità dell’esperienza cambia quando cambia il modo in cui ci si rivolge all’altra persona.
Per questo è fondamentale allenarsi a usare una comunicazione verbale che includa, protegga e legittimi - senza ridurre la persona a un’infanzia perenne, senza scivolare nel pietismo e senza filtrare tutto attraverso la lente clinica.
Parlare di desiderio, piacere, limiti e consenso con una persona con disabilità non significa “semplificare”, bensì trovare parole accessibili e rispettose, che mettano al centro la persona, non la diagnosi. Il lnguaggio cambia la postura: quando diciamo “ti va?”, “ti senti a tuo agio?”, “possiamo fermarci?”, non stiamo solo informando, ma stiamo mostrando che quella persona ha diritto di scegliere, rinegoziare, cambiare idea.
La dimensione del consenso non è un modulo da firmare. È una pratica continua che accompagna tutto il percorso, dalla comunicazione iniziale alla relazione che si costruisce nel tempo. Per funzionare davvero, deve essere esplicito, chiaro, continuo e reversibile. Vale per chi riceve un servizio, ma anche per chi lo offre. Nessuna prestazione - affettiva, sessuale, educativa - può essere proposta senza condizioni di sicurezza, rispetto e libertà.
Nella disabilità, tutto questo richiede più tempo, più cura e strumenti adatti. Ma non è un ostacolo: è un investimento nella qualità. Parlare con chiarezza, verificare il consenso, rispettare i limiti, significa costruire un clima dove nessuno si sente forzato, dove il piacere è possibile perché nessuno è in pericolo.
Strumenti pratici per un linguaggio accessibile e protettivo
Nel mio lavoro di coaching suggerisco sempre di iniziare dal linguaggio quotidiano. Non serve inventare formule complesse: bastano frasi semplici, ripetibili e coerenti. Questo vale sia per chi accompagna persone con disabilità, sia per chi lavora nel sociale, nell’educazione o nella sanità.
Dire, ad esempio, «Hai voglia di parlarne?» o «Ci sono cose che ti fanno sentire a disagio?» è diverso dal chiedere «Va tutto bene?» - che spesso presuppone una risposta automatica. Il linguaggio del consenso è fatto di domande aperte, senza pressione, senza aspettative. Si può proporre di usare simboli, immagini, esempi concreti, oppure costruire insieme una griglia di segnali, in caso di disabilità comunicativa.
Nelle strutture, è utile creare materiali scritti che descrivano cosa succede nei percorsi: chi accompagna, con quali limiti, con che regole. È fondamentale inserire sempre la possibilità di fermarsi, di cambiare idea, di riparlarne in un secondo momento. Questo vale anche nei progetti che coinvolgono operatori affettivi, educatori alla sessualità o OEAS: la trasparenza protegge tutte le parti coinvolte.
Le parole sono anche strumenti di difesa. Quando famiglie, operatori e utenti condividono una grammatica comune, l’ansia si abbassa, il rischio si riduce e il desiderio può emergere con più libertà. Come sex coach, dico spesso che non esistono formule magiche - ma che il modo in cui parliamo può cambiare radicalmente le connessioni che possiamo costruire, dentro e fuori di noi.
Oltre il tabù: affrontare la controversia senza negare i bisogni
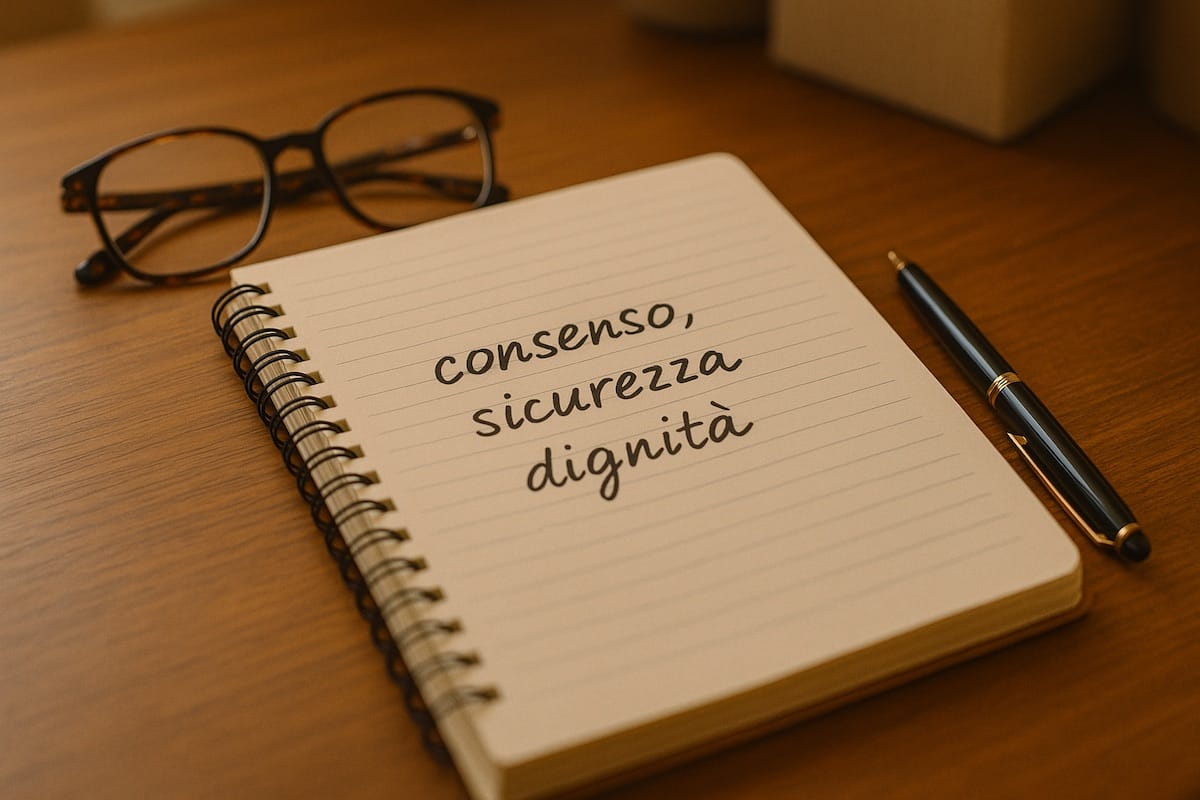
Affrontare il tema dell’accesso alla sessualità per le persone con disabilità significa anche entrare in una zona di dibattito complesso, dove si intrecciano diritti, paure, bisogni reali e confini etici. È comprensibile che ci siano resistenze: il tema tocca corde profonde - la vulnerabilità, il corpo, l’autonomia, la possibilità di desiderare.Ma come sex coach, so che evitare il conflitto non è sempre la strada migliore. Occorre imparare a starci dentro, con strumenti e discernimento.
Uno dei nodi più delicati è la confusione tra assistenza alla sessualità e sex work. In molti contesti, queste due realtà vengono sovrapposte o contrapposte, generando fraintendimenti e stigmi da entrambe le parti.
È importante chiarire: l’OEAS non fornisce prestazioni sessuali, ma propone un accompagnamento educativo sul piano corporeo, affettivo e relazionale, all’interno di un codice etico definito, con formazione specifica e supervisione costante. Non si tratta di offrire un servizio erotico, ma di creare le condizioni perché una persona con disabilità possa entrare in contatto con il proprio corpo, esplorare il desiderio, riconoscere i propri limiti e vivere esperienze di intimità con maggiore consapevolezza e dignità.
Le paure sono legittime: nessuno vuole esporre le persone vulnerabili a rischi di abuso, dipendenza o manipolazione. Proprio per questo serve un quadro chiaro, con percorsi tracciabili, professionisti formati e strumenti di verifica. Dove manca questa cornice, il rischio reale è che tutto avvenga nell’informalità, senza protezioni.
Non servono scorciatoie ideologiche. Serve costruire un linguaggio condiviso, una cultura del rispetto e della trasparenza, e soprattutto riconoscere che il bisogno esiste e non può essere rimosso con il silenzio.
Tracciabilità, formazione e protezione: cosa serve davvero
Spesso, quando si discute di OEAS, lovegiver o percorsi di affettività assistita, il dibattito si arena sulla domanda sbagliata: “È giusto o sbagliato?”. Come sex coach, preferisco spostare l’attenzione su un’altra domanda: “Come lo rendiamo sicuro, accessibile, rispettoso?”.
La tracciabilità è la chiave. Qualsiasi figura che entri in uno spazio così intimo deve avere una formazione certificata, un ambito di azione definito, un codice deontologico sottoscritto e la possibilità di confrontarsi in supervisione.
Un esempio positivo viene da alcune esperienze europee, dove il lavoro è integrato nei sistemi sociosanitari, con équipe multidisciplinari, ruoli complementari e monitoraggio degli interventi. Non si tratta di copiare quei modelli, ma di capire cosa possiamo adattare nel contesto italiano.
Anche senza una legge, oggi è possibile costruire percorsi formativi riconosciuti, creare spazi di confronto tra operatori, definire linee guida locali e attivare reti di supporto tra pari.
Un altro pilastro è la valutazione del rischio. Quali sono i contesti in cui attivare certi interventi? Quali segnali richiedono prudenza o sospensione? Chi verifica che ci sia consenso, idoneità, libertà di scelta? Queste domande vanno affrontate prima - non dopo - e condivise con famiglie, professionisti e persone coinvolte.
Infine, la protezione. Proteggere non significa vietare. Significa costruire uno spazio in cui desiderio e sicurezza possano coesistere. Dove chi riceve ha il diritto di sapere cosa aspettarsi e di fermarsi in ogni momento. E dove chi offre ha gli strumenti per lavorare con responsabilità, senza portare tutto sulle proprie spalle.
Cosa possono fare oggi famiglie, operatori e strutture
In assenza di una legge nazionale chiara, è naturale sentirsi disorientati. Ma l’assenza di norme non è mai una scusa per restare fermi. Nelle mie sessioni, lavoro spesso con chi si trova nel mezzo - famiglie che cercano risposte, operatori che non vogliono fare errori, strutture che hanno paura di esporsi. La buona notizia è che ci sono molte azioni possibili già da ora, alla portata di chi vuole davvero costruire spazi rispettosi, protetti e accessibili.
Anche senza un riconoscimento formale della figura dell’OEAS, si può già fare cultura del corpo, del consenso, dell’affettività. Le famiglie possono chiedere percorsi di educazione sessuale accessibile, confrontarsi con professionisti del settore, smettere di trattare la sessualità dei propri figli come un tabù.
Gli operatori sociali, sanitari e scolastici possono formarsi, ascoltare, integrare nuove competenze nella relazione di aiuto. Le strutture possono creare policy interne su privacy, prevenzione abusi e gestione dei limiti, dando un segnale concreto di presa in carico.
L'accesso alla sessualità, come quello a qualsiasi altro aspetto della salute, richiede linguaggi chiari, ambienti accoglienti e persone disposte a mettersi in gioco. Nessuno chiede di diventare esperti dall’oggi al domani. Ma cominciare a nominare il tema, ad ascoltare senza giudicare, a chiedere aiuto quando serve è già un cambio di passo importante.
Da dove iniziare? Educazione, linguaggio, policy
Per le famiglie, il primo passo è spesso rompere il silenzio. Parlare di corpo, di emozioni, di relazioni, fin da piccoli, con parole adatte all’età e alla persona, aiuta a costruire fiducia e consapevolezza. Cercare professionisti che sappiano guidare questi percorsi è parte della cura, non un fallimento del genitore. La sessualità, se ignorata, non sparisce: semplicemente si esprime in forme meno visibili, e spesso più rischiose.
Per gli operatori, è utile chiedersi: sto includendo anche l’aspetto affettivo e relazionale nel mio lavoro? Come parlo di consenso, di piacere, di limiti? Ho strumenti per accompagnare queste tematiche in modo protetto? Spesso basta una formazione mirata, qualche ora di aggiornamento, un confronto in équipe per cambiare radicalmente l’approccio.
Per le strutture, invece, il punto critico è spesso organizzativo: chi si occupa di privacy? Chi è il referente in caso di segnalazioni? Ci sono spazi pensati per l’intimità? Come viene gestita la comunicazione tra famiglia, operatore e utente? Anche senza una legge, inserire questi aspetti nelle policy interne è un segno di responsabilità e lungimiranza.
Ripartire dal corpo, dal consenso e dalla realtà
La sessualità non è un privilegio per pochi né un tema da rinviare a “quando ci sarà una legge”. È una parte viva dell’identità, un terreno dove si intrecciano desiderio, relazione, sicurezza e libertà. Per le persone con disabilità, parlare di accesso alla sessualità significa riconoscere un diritto spesso ignorato e offrire strumenti per viverlo con dignità.
Come sex coach, so che ogni percorso è unico. Ma tutti iniziano dalla stessa domanda: “Cosa mi serve per sentirmi sicurə, rispettatə e liberə di scegliere?”. Costruire spazi, parole, figure professionali e reti che possano rispondere a questa domanda è un gesto politico, relazionale e culturale.
In questo quadro, progetti editoriali come SimpleMedia (la sezione informativa di SimpleEscort) fanno una cosa preziosa: parlano in modo chiaro, accessibile e senza stigma di questi temi, contribuendo a spostare il discorso dalle semplificazioni alla complessità reale, senza vergogna né sensazionalismo, e con una cura reale per chi lavora, chi accompagna e chi desidera vivere una sessualità piena e libera.
Ripartire dalla realtà, anche quando è scomoda, è un atto di rispetto. Vuol dire accettare che il desiderio non è sempre facile da gestire, ma merita attenzione e accompagnamento. Vuol dire non aver paura di dire “non lo so, ma voglio capire meglio”. Vuol dire creare possibilità dove oggi c’è solo silenzio o paura.
La sessualità non può essere delegata né negata. Deve essere accompagnata, resa accessibile, messa in sicurezza. E tutto questo comincia da noi: dai nostri linguaggi, dai nostri gesti, dalle scelte professionali che facciamo ogni giorno.

